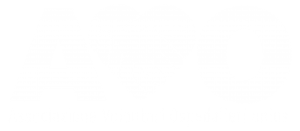
“La buona vanga” (E. Longhini): intervista a Claudio Lodoli
8 dicembre 1967: con l’episodio del “bicchiere d’acqua”, che tutti conosciamo, germoglia la piantina dell’AVO destinata a diventare un albero robusto.

Erminio Longhini
LA BUONA VANGA
Intervista a Claudio Lodoli, 21 novembre 2018
A cura di Loredana Pianta
Oggetto di questo dialogo con Claudio Lodoli è il libro in fase di pubblicazione “La buona vanga”, autobiografia di Erminio Longhini raccolta e curata, per l’appunto, dal past-president della Federavo con l’autorizzazione della famiglia Longhini. Un libro che tutti aspettiamo perché racconta la vita, le opere e il pensiero del fondatore dell’AVO attraverso le parole del protagonista.
Il testo, condiviso con l’autore nella prima stesura, è stato scrupolosamente verificato in ogni sua parte e perfezionato dal curatore grazie ai contributi determinanti dei figli del professore, e alla collaborazione delle persone che gli sono state più vicine nella vita professionale. Come ciliegina sulla torta, Padre Arnaldo Pangrazzi ha accettato di scrivere la prefazione.
Claudio, dove nasce l’idea di raccontare la vita del professor Longhini, e perché si tratta di un’autobiografia e non di una biografia?
Dobbiamo tornare a un sabato sera di settembre del 2005. Alla ripresa delle attività dopo le vacanze estive, Erminio Longhini mi ha convocato a Milano per fare il punto sui progetti in corso, con una cenetta a seguire. Terminata la riunione ci siamo trasferiti nel tinello, mentre Nuccia è impegnata in cucina. Il televisore è acceso, ma serve soltanto di sottofondo alla lieve chiacchierata che scioglie la concentrazione delle due ore precedenti.
Da tempo ho parcheggiato nella mente un’idea che indugia a prendere forma: il clima sereno di questa serata mi incoraggia, penso sia il momento giusto per esprimerla … ma Nuccia arriva con una zuppiera fumante, e allora mi taccio per fare degna accoglienza alla padrona di casa. Erminio apre una bottiglia di vino, leviamo i bicchieri e si mangia. Come sempre la conversazione è piacevolissima, grazie anche alla giovialità di Nuccia che ha il dono di farmi sentire uno di famiglia. Così, approfittando di una pausa, richiamo la loro attenzione e, con ironica solennità, annuncio: «Stasera ho da farvi una proposta». Centrato l’obiettivo di bloccare la cena prima del dolce, sfrutto la sorpresa e proseguo: «In dieci anni mi avete messo a parte dei vostri ricordi, e di tanti episodi di una storia affascinante che merita di essere raccontata». Mi fermo un istante e, cogliendo il punto interrogativo nei loro sguardi, rivolgo al professore una domanda diretta: «Te la sentiresti di lavorare con me alla tua biografia?». Non c’è che dire, se lo volevo spiazzare ci sono riuscito, ma se pensavo che ciò avrebbe spianato la strada al suo «sì», sbagliavo.
Nuccia guarda il volto incerto del marito, e temporeggia con qualche parola del tipo: «Ma lo senti il Claudio? … Che bello! Certo di cose da scrivere ce n’è per due libri …». Erminio, invece, si è fatto serio. In visibile imbarazzo, con voce sottile e un poco sforzata, fra un «uhm, insomma» e l’altro, mi risponde di aver sempre rimosso l’idea perché è convinto che le tante cose che ha fatto non siano tutta opera sua. Conosco bene il Presidente, so che non nasconde mai l’orgoglio dei suoi successi e della magnifica carriera: parla volentieri dei numerosi lavori scientifici pubblicati, della “sua” Divisione di Medicina a Sesto San Giovanni, parla dell’AVO, molto e con passione, si illumina nel ricordo ancora fresco della cerimonia al Quirinale per il conferimento della medaglia d’oro al merito della Sanità pubblica. Ama descrivere le situazioni, raccontare i fatti, ma rifugge dalla vanità. Così conclude il suo giro di parole con una frase iconica, che rimanda al patto spiritualmente stipulato quarant’anni prima nella grotta di Lourdes, ai piedi della statua dell’Immacolata: «Io sono stato soltanto una buona vanga».
Perché tante esitazioni?
Secondo me in quel momento temeva che il libro potesse offrire al pubblico una rappresentazione celebrativa, oleografica di sé. Per questo non mi sono arreso.
Allora raccontaci come è andata a finire!
Restiamo a guardarci tutti e tre per qualche secondo, poi lancio una proposta più specifica: spiego che potremmo costruire insieme un lavoro basato su interviste, discorsi, testimonianze, documenti. Si parlerà soltanto di fatti certi, descritti e narrati in maniera oggettiva e senza orpelli. «Impostata così» aggiungo «dalla tua biografia uscirà l’immagine molto umana, realistica di un medico che ha contribuito allo sviluppo di un Sistema sanitario fondato sulla qualità degli operatori, sul rispetto della dignità e del benessere degli ammalati. Insomma, questo libro racconterà una storia non romanzata che servirà molto più ai lettori che a te».
Per farla breve, non approva esplicitamente ma sorride con uno sguardo eloquente. Nuccia si alza, prende una grande scatola di cioccolatini e una bottiglia di buon whisky. È andata.
Scusami, Claudio, finora hai parlato di biografia, non di autobiografia …
Vero, perché così è nato il progetto. Erminio non se la sentiva di scrivere di sé in maniera estesa, e poi era molto critico sul proprio stile narrativo. No, in quel momento non avrebbe accettato mai la proposta di un’autobiografia.
Va bene, ma perché il libro è presentato come autobiografia?
Domanda logica, me l’aspettavo. Ascoltami. Il lavoro era iniziato secondo i piani: inviavo ad Erminio per fax una serie di domande. Nel frattempo raccoglievamo suoi materiali di lavoro, testi di discorsi, articoli pubblicati in Noi insieme e in altre riviste. Lui dopo un po’ di tempo, sempre via fax, mi trasmetteva ciò che aveva scritto facendo riferimento alle mie domande, e quando aveva dei dubbi mi telefonava.
Scriveva in modo molto sintetico, con periodi brevi in rapida successione che io integravo con i materiali che avevamo accumulato. Spesso gli capitava di illustrare degli avvenimenti dando per scontate le premesse a me ignote, e perdevo il filo del discorso; quando non riuscivo a trovare il bandolo, lo chiamavo dopo cena e con pazienza ricostruivamo insieme il puzzle. Periodicamente restituivo le pagine riordinate, Erminio leggeva tutto, faceva le sue osservazioni e di tanto in tanto ci si vedeva a Milano per condividere tutto il lavoro fatto. Purtroppo, in questa modalità un po’ farraginosa si procedeva a rilento; tuttavia, data la distanza e la ritrosia del Presidente nei confronti del “calcolatore” (non usava il termine computer), non si poteva fare diversamente.
La stai prendendo alla larga …
Se vuoi posso stringere, ma credo sia utile per i lettori comprendere le ragioni della lunga gestazione di un piccolo libro, iniziato nel 2005 e non ancora pubblicato.
Ok, ma ora concludi!
Certo, perché siamo giunti al momento in cui il progetto ha rischiato il naufragio.
Alla fine del decennio le preoccupazioni per il peggioramento della salute di Nuccia incidevano sullo stato d’animo di Erminio che, a sua volta, nello stesso periodo si era dovuto sottoporre a un trattamento terapeutico di una certa importanza. La situazione critica ebbe riflessi anche sul mio stato d’animo e la presidenza della Federavo assunta ad aprile 2010, sommata ai molteplici incarichi professionali da onorare, aveva fatto il resto. Il libro al momento fu accantonato con il magro bottino di una quarantina di pagine. A quel punto ho capito che non se ne sarebbe fatto più nulla.
Invece?
Invece, proprio in quei tempi difficili si sono create le condizioni affinché qualche anno dopo il lavoro fosse ripreso, approfondito e perfezionato.
Nel 2013, alla prima riapertura del file, provai il disappunto già sperimentato quando lo avevo archiviato. «Cosa posso fare di queste poche pagine?» mi domandavo.
Piuttosto demoralizzato, provai a rileggerle tutte di seguito ad alta voce, e mi piacquero. Le lessi ancora, con maggiore attenzione per concludere che, seppure per sommi capi, quel testo copriva la vita di Erminio dalla nascita più o meno fino al 2009.
Incoraggiato, ripresi il file dall’inizio e lo ripassai tutto al vaglio, eseguendo interventi redazionali, correggendo refusi, inserendo elementi tratti dall’archivio per conferire maggiore completezza allo scritto. Infine, divisi tutto in paragrafi corredati di titoletti, e cominciai a immaginare un primo indice.
La condizione non era sostanzialmente cambiata: ciò che avevo in mano era soltanto una bozza allo stato grezzo che avrebbe richiesto ancora molto tempo e tanto lavoro; eppure, dopo averla confrontata con la redazione precedente, decisi di rompere gli indugi e di continuare il lavoro. Di seguito proporrei alcune citazioni tratte da vari capitoli in sequenza:
Un bambino irrequieto
Ero un bambino irrequieto, e penso che l’aspetto caratteriale sia stato accentuato dal mio essere figlio unico: situazione obiettivamente non agevole, perché ti manca colui o colei che denunci la misura dei tuoi limiti. In effetti da medico ho provato molta compassione per il figlio unico, quale persona priva di una pietra di paragone all’interno della famiglia. Io avevo la sensazione che mi venisse chiesto sempre il «meglio» in senso assoluto: ma per me cos’era il «meglio»? Era prima di tutto vedere mia madre contenta di me. Fu proprio lei che contribuì alla formazione di questa personalità orientata sempre al meglio. Ciò ha giocato un ruolo molto importante in alcuni momenti della mia vita, perché, di per me, non sarei stato l’individuo socialmente e culturalmente pronto per fare il ricercatore che poi sono diventato.
[…]
Ho perduto il conto delle monellerie, ma ne cito una che ben rappresenta tutte le altre.
La mamma teneva a vestirmi bene e, grazie alla sua esperienza di sarta, cuciva per me dei begli abiti, e poiché negli anni Trenta era di moda lo stile marinaretto, mi confezionò con tutto il suo impegno un magnifico vestito bianco con le bordature e il solino blu sulle spalle. Completate le finiture, un pomeriggio me lo fece indossare per andare ad attendere il papà all’uscita dal lavoro con l’abito nuovo di zecca.
Mentre lei si preparava, mi affacciai a una finestra e vidi degli operai che gettavano l’asfalto sulla strada. Furono attimi: sgattaiolai per le scale e, inforcata la bicicletta, raggiunsi la zona con il catrame appena steso e lisciato, e spinsi forte sui pedali per lasciarci la scia e far arrabbiare i poveretti che stavano lavorando. Naturalmente non riuscii a mantenermi in equilibrio e caddi: il seguito lo lascio immaginare.
La guerra devasta Milano, e la nostra vita
La guerra ha segnato profondamente la mia adolescenza. Le avvisaglie della sua durezza si erano manifestate con i primi raid dell’aviazione britannica compiuti su Milano, dopo la dichiarazione di guerra alla Francia e alla Gran Bretagna. Una sera stavo tornando a casa con i miei genitori e ad un tratto suonarono le sirene dell’allarme aereo. Erano trascorsi pochi minuti – neppure il tempo di raggiungere un rifugio – e i bombardieri erano già arrivati sulla città. Nonostante le rassicurazioni dei miei genitori, fu impressionante entrare in quei sotterranei male illuminati, insieme a tanti sconosciuti che reagivano nelle maniere più diverse, sapendo che sopra di noi piovevano bombe dal cielo. Era difficile per me comprendere la ragione di tutto questo: perché la guerra?
Quando l’allarme cessò, in semioscurità ci avviammo verso casa attraverso un percorso a zig-zag tra strade sventrate e sepolte dalle macerie degli edifici crollati.
Arrivammo a Porta Romana, finalmente. Di fronte alle rovine del palazzo dove abitavamo, del quale rimanevano in piedi solo alcuni muri, restammo muti. Non avevamo più nulla.
I bombardamenti ripresero nelle prime ore della notte ma con minore efficacia, e in breve si esaurirono.
In quella emergenza fummo accolti dalla zia Valeria, che abitava in un grande caseggiato di Via Venini, e la Provvidenza volle che in quello stesso complesso il Comune di Milano mettesse alcuni appartamenti a disposizione dei cittadini che avevano perduto le loro case. Anche i miei genitori ottennero una di quelle abitazioni, ma pensarono di allontanarmi da Milano, ritenendo che sarei stato più al sicuro presso i nostri parenti a Varese, dove continuai gli studi.
Il capitolo della mia infanzia e della prima adolescenza, tanto intensamente vissute nel quartiere di Porta Romana, si era concluso.
Va bene, farò il medico
Nei miei sogni di ragazzo mi vedevo sommergibilista, ma l’alta statura era un ostacolo per quella carriera. In ogni caso per ragioni familiari fui esonerato dal servizio militare e il problema non si pose più. Quanto agli studi, fin dall’inizio delle scuole superiori il mio desiderio era stato diventare ingegnere minerario, perché l’idea di estrarre dalla terra qualcosa di utile mi attirava molto.
I miei genitori, però, si aspettavano altro da me. Soprattutto mio padre continuava a dirmi: «Come sarebbe bello avere in casa un dottore!». Riflettei per un bel po’, e alla fine giunsi alla conclusione che i sacrifici andavano ricompensati: mia madre e mio padre ne avevano fatti tanti per mantenermi agli studi, e altri sarebbero stati necessari negli anni a venire. Mi iscrissi alla Facoltà di Medicina dell’Università Statale.
Quando terminai questo lavoro preliminare, quelle quaranta pagine in semplice sequenza, rivedute e ristrutturate erano diventate sessanta. Ma ciò che più contava era l’organicità propria di un testo narrativo che avevano assunto. Allora mi venne in mente la famosa vanga di Erminio Longhini: applicando lo stesso principio alla genesi di questa piccola opera, lui sarebbe stato il vangatore (l’autore) ed io soltanto una buona vanga (ovvero l’estensore).
Quando ci rimettemmo all’opera gliene parlai, lo convinsi della bontà di questa soluzione e il lavoro riprese con buona lena.
La biografia era diventata una vera autobiografia. Ho risposto bene?
Ci hai messo un po’ ma sì, hai risposto bene. E allora adesso parlaci anche della seconda parte del libro
Certamente. Dopo la morte di Nuccia il 27 dicembre 2012, ho cercato di essere quanto più possibile vicino a Erminio. Lo andavo a trovare spesso, lo aggiornavo sull’andamento della Federavo che viveva un periodo difficile e gli chiedevo dei consigli. Inoltre, come ti ho appena detto, il 2013 è stato anche l’anno in cui abbiamo ripreso le fila dell’autobiografia, rileggendo il testo esistente, colmandone i vuoti, segnalando i dubbi da sciogliere e le contraddizioni da sanare. Abbiamo infine integrato i capitoli più stringati, ampliando la narrazione con i suggerimenti che Erminio mi dava in presenza o per telefono, e con i suoi materiali di lavoro che avevamo recuperato.
Così furono ricostruiti con cura anche gli avvenimenti che precedettero la nascita dell’AVO:
Dunque, nel 1974 la salute malferma di un Paese in difficoltà si rifletteva sulle situazioni di crisi a livello locale, amplificandone gli effetti: Sesto San Giovanni ne era un esempio lampante. Il clima pesante non stimolava l’ottimismo della gente, e la preoccupazione per le sorti dei posti di lavoro mal si conciliava con la mia proposta di un impegno gratuito, da svolgere per puro altruismo in un luogo associato alla negatività della sofferenza e del dolore.
Guardai al rovescio della medaglia, e conclusi che proprio nelle difficoltà si apprezza il valore della solidarietà. Le persone che avevo individuato avevano le qualità morali per riuscire nell’intento, ma restava l’opposizione di Nuccia; tuttavia dentro di me confidavo fortemente sulla sua capacità di guardare oltre la contingenza, e non sbagliavo: il suo No divenne un Forse e poi un Sì.
Superato quest’ultimo ostacolo prevalse la fiducia e tutto il gruppo si disse pronto a impegnarsi.
Quando la discussione si fece più concreta, e la prospettiva di una effettiva attuazione divenne realistica, Goffredo Grassani, titolare di uno degli studi legali più importanti di Milano, richiamò tutti all’esigenza di conferire una connotazione giuridicamente sostenibile ai cosiddetti «amici del malato» partoriti da una mente, la mia, che per deformazione professionale era orientata a semplificare le complessità.
L’interpretazione che davo alla professione di medico era stata una libera scelta: trascorsa una ventina d’anni dai tempi della gavetta al Policlinico e al Niguarda, continuavo a lavorare dalla mattina presto fino a notte fonda. Quindi, avevo assoluto bisogno di persone che mi sostenessero in quella nuova – all’epoca singolare – avventura.
Questo lavoro certosino di revisione è servito anche per riscrivere fatti importanti, rivedendone la collocazione nel tempo e nei luoghi. Vuoi un esempio? Il leggendario episodio del bicchiere d’acqua, ricondotto definitivamente al Niguarda e nella data corretta: 8 dicembre 1967, ben otto anni prima della nascita dell’AVO.
Erminio però non volle estendere la parte autobiografica oltre il limite temporale delle pagine scritte in origine: l’ultima conteneva un riferimento al corso di formazione per dirigenti del volontariato, organizzato nel 2009 con l’Università Cattolica. Di fatto il suo testo terminava con la seguente conclusione:
Ciò che ho narrato, ha il solo fine di ribadire la mia convinzione che le attività qualificate di ricerca sono la garanzia della sopravvivenza e dello sviluppo di qualsiasi grande organizzazione. Se la ricerca è concentrata in una persona, resta nell’ambito della filosofia – e penso subito a Cartesio – ma non è società, perché l’uomo diventa persona nella società. Io avrei potuto inventarmi anche diecimila soluzioni importanti nella medicina, avere più grandi intuizioni nel sociale, ma se non ci fossero stati tutti coloro che ho avuto con me a sostenermi con il loro studio e il loro impegno, questa storia non sarebbe stata mai scritta.
Al contrario, non termina qui il libro nell’attuale stesura, elaborata nell’arco di un anno e mezzo dalla morte di Erminio. Infatti, il Presidente, finalmente sganciato dai vincoli della struttura narrativa e dalle esigenze cronologiche degli scritti autobiografici, aveva accolto la mia proposta di completare l’opera con una seconda parte dedicata ad approfondimenti sulle grandi questioni emerse nel racconto. È stata un’esperienza straordinaria. Durante gli incontri, le sue parole si trasformavano d’improvviso in cascate di sapienza e di idee che scorrendo si rispecchiavano nella sua mente e divenivano più limpide e chiare. Allora, compiaciuto, ritornava con fervore sul concetto appena espresso, affinandolo e perfezionandone l’esposizione. Nell’arco di tre anni è riuscito ad ampliare e a commentare tutti i temi che aveva più a cuore, generando un distillato puro di riflessioni alte, emozionanti. Cito solo qualche esempio:
Sulla reciprocità
La reciprocità vale in ogni dimensione e in ogni tipo di rapporto. Quando sono diventato primario a Sesto San Giovanni, una delle premesse era stata la volontà di accogliere il povero come il ricco: ecco perché quando miei amici o personalità importanti venivano ricoverati nel mio reparto avevano gli stessi agi di tutti gli altri; gli stessi della vecchia signora che non interessava più a nessuno. La reciprocità, infatti, non consente differenze di trattamento e non cambia a seconda di chi hai di fronte. È questa la visione che mi ha portato a considerare l’incontro con i malati come momento di reciprocità, in cui alla mia visita di medico potevo aggiungere un messaggio: «Ho capito la tua malattia, e per tutto quanto mi riguarda cerco di garantirti il meglio possibile… Ma tu realmente come ti senti?». Spesso, e in condizioni molto diverse, la risposta è stata: «Mi sento solo».
La solitudine in apparenza non avrebbe dovuto essere un problema per i ricoverati, perché tutto sommato i parenti c’erano. Purtroppo, quando venivano a trovarli, insieme alla compagnia portavano anche i propri problemi, e andando via lasciavano quei poveri diavoli con un carico di preoccupazioni.
Sulla fede
Vedi? L’amore di Dio è un amore che circola lungo quel triangolo.
Ma se è amore deve uscire dal moto circolare perpetuo per estendersi oltre quel triangolo chiuso. Quindi emerge il problema della creazione: Dio fa l’atto supremo di dare forma a un essere (umano) creato a sua immagine e simiglianza. Dunque in questo essere non può mancare un requisito essenziale: la libertà. L’uomo però ne fa cattivo uso: «Voglio essere come te», dice a Dio. Ecco lo strappo fra Uomo e Dio che non era evidentemente possibile ricucire. L’incarnazione del Figlio è il «dono di sé» da parte di Dio che offre la salvezza all’Umanità mandando sulla Terra Gesù che è vero uomo nel vero Dio. Gesù, senza peccato che viene fra noi a farsi carico dei peccati degli uomini.

Sulla fine dei giorni
Negli ultimi giorni, quando la speranza è ormai svanita, ecco sorgere la confidenza.
[…]
Quando la vita è al tramonto, infatti, non mancano i momenti bui, ma neppure i momenti di luce, di letizia, di consolazione.
Fra noi si era stabilita una tal sintonia che potevamo discutere di questioni impegnative in qualsiasi situazione, un paio di volte anche al parco. La prima, mentre seguivamo il suo cane che scorrazzava; l’altra, quando il fisico non glielo permetteva più, seduti su una panchina. Certamente il luogo d’elezione restava la stanza di lavoro, nella tranquillità della sua casa. Ascoltavo, facevo delle domande e il Presidente con pazienza e grande apertura rispondeva sempre a tutto. Al ritorno, in aereo, scrivevo sul mio quaderno; scrivevo sul quaderno anche dopo le cene a casa sua e lui ne era lieto, perché sapeva che quelle parole scritte non sarebbero andate disperse. Talvolta, quando il discorso si faceva più complicato, gli chiedevo il permesso di registrare le conversazioni e sono stato sempre autorizzato a farlo.
Verso la fine dei suoi giorni, i colloqui divennero più profondi, confidenziali; il medico illustre sperimentava l’asprezza della malattia e parlava di sé “dall’altra parte”: una condizione che ha accettato con grande difficoltà.
Sto male, mi sento spossato, il fisico non regge. Fatico anche a fare pochi passi, ma la mente è lucida. La cosa che più mi fa soffrire e mi avvilisce, però, è quella di aver smesso di fare il medico.
La sua salute peggiorava: piastrine ridotte, grande spossatezza, fatica nel camminare, inappetenza. Percepivo con tristezza la sua improvvisa fragilità.
Tutto questo è confluito nella seconda parte del libro, capitolo ottavo: Visto da vicino.
I giorni dell’addio, invece è il titolo del nono e ultimo capitolo. Il più breve, ma anche il più difficile da scrivere per i suoi familiari che hanno dato il loro fondamentale contributo, e anche per me che l’ho abbracciato qualche ora prima che perdesse conoscenza.
Non ritengo opportuno inserire alcuna anticipazione, riservando a queste pagine un angolo privato, in cui entreranno con rispetto coloro che vorranno leggere il libro quando sarà stampato.
Claudio, sei un volontario AVO ed hai ricoperto tutte le cariche previste dalla nostra organizzazione, fino alla presidenza federale. Per vent’anni hai avuto il privilegio di lavorare fianco a fianco con il Presidente fondatore.
Chi era Erminio Longhini?
Vedi, è davvero difficile rispondere a questa domanda nello spazio ragionevole di una intervista, ma provo a tracciare un rapido “schizzo a matita” ricordando il mio primo incontro con lui. Quell’uomo imponente e raffinato, accompagnato dalla fama di grande medico e di fondatore di un’innovativa associazione di volontariato sanitario, di primo acchito incuteva molta soggezione. Ecco l’attacco dell’introduzione:
Sabato 25 maggio 1996, sera. La scena si apre nell’androne di un piccolo albergo di provincia, in un ambiente modesto che rispecchia l’aspetto di tutto l’edificio, fra l’altro privo di ascensore. D’improvviso, in cima alla rampa di scale che conduce al primo piano, compare un uomo elegante, alto, dalla corporatura imponente e dal portamento regale. I suoi capelli rivelano un’età non più giovane, ma il passo è deciso ed egli scende con disinvolta lentezza i gradini, mentre un sorriso sfolgorante illumina il suo volto fascinoso irradiando le persone che sono di sotto ad attenderlo.
Una volta rotto il ghiaccio, il professore appariva la persona aperta, cordiale e perfino timida che realmente era. L’istintiva riservatezza era accentuata sia dalla natura della sua professione, sia dalla delicatezza del suo ruolo in una grande associazione. Parlava poco della sua vita privata ma, quando se ne dava l’opportunità, lasciava trasparire l’orgoglio per la sua famiglia, per i suoi figli.
Nonostante questa premessa, v’è da dire che non era poi così difficile avvicinarlo e stabilire con lui un rapporto cordiale, ma conquistarne la fiducia era tutt’altra questione, come anche lavorarci insieme.
Mi sembra che tu abbia ottenuto tutta la sua fiducia
È stato un percorso impegnativo che, nelle nostre diversità, abbiamo compiuto insieme. Ho sentito tutta la responsabilità di questo privilegio, e ho fatto il possibile per esserne all’altezza. Longhini era dotato di una straordinaria intelligenza e aveva un carattere molto determinato: quando si convinceva della bontà di una decisione, fargli cambiare idea era un’impresa quasi impossibile. Allora per evitare le situazioni di stallo, avevo imparato ad aggiornarlo puntualmente sullo stato di avanzamento di ogni progetto, raccogliendo e discutendo volta per volta le sue osservazioni; così si arrivava alla conclusione con soluzioni condivise. A poco a poco, con i buoni risultati, è nata anche la fiducia.
E alla fiducia è seguita l’amicizia …
Sì, è così. Ma entrai con assoluta discrezione nella sua casa, e quel primo incontro nello studio segnò l’inizio di una lunga frequentazione. Così nel tempo ho potuto scoprire l’altro volto del professore.
Parco nel mangiare, Erminio Longhini apprezzava la buona cucina, e con lui a tavola la conversazione non languiva mai: allegro e ironico, per ogni argomento aveva sempre aneddoti interessanti da raccontare, molti dei quali sono stati riportati nell’autobiografia. Ne cito uno da lui più volte evocato, che riguarda l’AVO:
Non ho buona memoria per le date, ma il 10 luglio non lo dimenticherò mai: a Sesto San Giovanni fui convocato da un autorevole esponente sindacale che, con espressione arcigna, mi affrontò esordendo: «Ho faticato per mettere fuori le monache dall’ospedale. Professore, mi crede così stupido da non capire che lei vuole sostituire con i suoi volontari cattolici le religiose finalmente uscite dal giro?».
Le monache che tanto lo avevano urtato erano suore infermiere irlandesi (dette Blue Sisters dal colore del loro mantello), che l’Arcivescovo di Milano – Giovanni Battista Montini – aveva voluto all’Ospedale Maggiore, dunque anche nelle sezioni staccate.
Si metteva male. Provai a imbastire una risposta, ma squillò il telefono: quello rispose subito, mi fece un cenno con la mano e volentieri tacqui. La conversazione con il suo interlocutore all’altro capo del filo si fece animata. L’uomo divenne rosso in volto, mise giù la cornetta e mi congedò bruscamente: «Adesso ho cose più importanti. Ne parliamo un’altra volta» disse.
Gli avevano appena comunicato che c’era stata un’esplosione all’ICMESA di Meda, a un passo da Seveso. Non si fece più vivo.
Amava il mare e già in primavera pregustava il momento in cui, con l’inizio dei suoi weekend a Camogli, avrebbe messo in acqua la barca:
Mi è sempre piaciuto nuotare, camminare, portare il cane al parco, leggere e pregare. Ho amato Camogli, meraviglioso paesino della Liguria, che considero il più bel posto del mondo, e lì, da buon abitudinario, ho trascorso tutte le vacanze estive sin dagli anni Settanta. La famiglia vi si trasferiva tra la fine di giugno e l’inizio di luglio; io lasciavo Milano il venerdì sera e rientravo il martedì mattina.
In agosto mi concedevo anche una decina di giorni tutti di fila, con il Ferragosto in mezzo. La mia giornata al mare: sveglia all’alba, giro col cane sulle balze della montagna attorno a Camogli, poi in scooter fino al porticciolo, uscita in barca, nuotata di un’ora e più; a mezzogiorno pranzo in mezzo al mare, poi dormita al sole, rientro in porto, a casa in scooter, ancora passeggiata con il cane in montagna, ritorno a casa in condizioni improponibili. Dunque, un bagno ristoratore e, perfettamente vestito, a Messa.
Scherzavamo spesso sulla rivalità nel calcio. Lui era appassionato del Milan e non perdeva una partita della squadra del cuore; a me non interessavano più di tanto le sorti della Juventus, ma quando mi diceva che essere juventino era un gran peccato (anche se meno grave di essere interista), ne approfittavo per scambiare con lui un po’ di battute pepate!
Tutti gli elementi della sua complessa personalità erano omogeneizzati nel substrato di uno stile di vita particolare. Metodico e abitudinario, scandiva la giornata secondo una precisa pianificazione funzionale alla gestione ordinata di tutti i suoi impegni: dalla Messa mattutina, alla lettura del Corriere della sera, alle attività professionali, alle passeggiate con il cane di turno (nella sua lunga vita ne ha avuti sette e tutti si chiamavano Jerry), alle ore di studio prima di andare a dormire.
Per restare sul tema ti racconto un fatto accaduto attorno al 2006. Mi trovavo a Milano per ragioni di lavoro e a fine giornata lo andai a trovare. Mi trattenne a cena, e nella lunga conversazione che seguì mi illustrò i progetti che intendeva sviluppare nell’arco di un biennio, confidando su una mia più intensa collaborazione. Sovrastato da cento impegni nel campo professionale e nell’AVO, gli dissi di non essere in grado di assumerne altri. Con uno sguardo sottilmente provocatorio mi rispose che dovevo imparare a dividere meglio il mio tempo. Non aggiunse altro, ma capii l’antifona e andai avanti come Dio volle.
Credo però che la scelta strategica di imporre un ordine rigoroso alla sua quotidianità, fosse anche il modo per contenere gli effetti delle tensioni che una vita tanto intensa non gli risparmiava.
Pur nella sua “umanità”, fino all’ultimo ha trasmesso di sé l’immagine di una personalità speciale, legata fortemente alla propria storia eppure capace di volare alto, di guardare oltre e di intuire gli scenari del tempo a venire.
È bene che mi fermi qui, rinviando il lettore al ritratto dal vero di Erminio Longhini, che emerge dalla lettura del libro. Spero si possa pubblicare presto.
Un’ultima domanda: perché questo libro?
In effetti la domanda è tutt’altro che banale. La comunicazione attuale concentrata sull’immediatezza contribuisce al disvalore della storia: la più seria conseguenza di ciò – per quanto ci riguarda – consiste nell’indebolimento del senso di appartenenza all’Associazione da un lato; dall’altro l’apertura a più libere interpretazioni della missione racchiusa nei principi fondativi. Il messaggio che si trae dalla lettura dell’autobiografia, conferma ciò che il Presidente ha sostenuto fino all’ultimo giorno: spazio all’evoluzione dell’AVO che deve essere adeguata ai cambiamenti imposti dal mutare dei tempi, ma nel rispetto dei valori della tradizione.
Nessun edificio si regge senza buone fondamenta, e tanto meno un’organizzazione complessa come l’AVO che ha le radici nella propria storia: il libro, dunque, è stato scritto certamente per far conoscere la vita di Erminio Longhini a chiunque abbia a cuore la difesa dei principi della buona sanità e della solidarietà. Ma la sua storia è inestricabilmente intrecciata con la storia dell’AVO che il Presidente ha voluto tramandare alle nuove generazioni di volontari.
Grazie Claudio, ora non ci resta che aspettare la pubblicazione dell’autobiografia che ci permetterà di conoscere meglio Erminio Longhini, e di acquisire maggiore consapevolezza della responsabilità che abbiamo assunto accettando di ereditare il suo più grande patrimonio: l’AVO. Toccherà a noi e ai giovani che verranno tutelarlo e metterlo a frutto.
