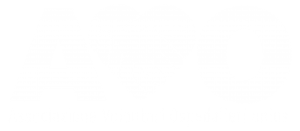
L’angolo dell’Etica: l’Io sofferente del volontario incontra la sofferenza

Mi chiedo. Cosa spinge oggi una persona a fare volontariato in ospedale, cioè ad intraprendere una frequentazione nel luogo che per antonomasia è il luogo del dolore e della sofferenza. La risposta sembrerebbe semplice se si considerasse che, al di là di un movente religioso o umanitario, ogni uomo di buon senso tende a dare una mano a chi gli sta vicino ed ha un qualsiasi bisogno.
Ma se si va oltre ad approfondire le possibili motivazioni che spingono verso questa forma di solidarietà in favore di chi soffre nel corpo, ma inevitabilmente anche nell’animo, emerge una indubbia complessità della risposta. Non fosse altro perché l’uomo contemporaneo in generale tende ad esorcizzare il male e la sofferenza, spesso negandola volontariamente, distratto da un sentimento eccessivo della vita e delle sue vicende. Come dire che in una realtà edonistica e turbolenta non c’è assolutamente spazio per il dolore in tutte le sue forme.
Invece il volontario ospedaliero fa un vero e proprio giro di boa e va controcorrente. Si dirige esattamente dove la solitudine, la sofferenza, la morte sembrano dominare la scena. Eppure non credo che questa sia una sfida. No. E’ semplicemente un comportamento di realismo esistenziale perché queste cose esistono nonostante tutto, anzi fanno parte integrante della vita. E sarebbe giusto che tutti seguissero questa rotta se davvero si volesse offrire a questa società super- tecnologica un più autentico percorso esistenziale. Nella mente del volontario ospedaliero si sommano diverse motivazioni a sottrarre un po’ del proprio tempo per avvicinarsi a chi vive una condizione di debolezza, di precarietà e spesso di pericolo per la propria sopravvivenza.
C’è indubbiamente in partenza una sensibilità particolare verso chi è malato. Ma c’è ancora un bisogno che diventa impellente di abbandonare il rito laico della corsa al benessere e al godimento per affiancare chi da questo rito è stato brutalmente escluso. C’è dunque preliminarmente la presa di coscienza della propria fragilità e del proprio limite che rende spontaneo e naturale affiancare chi questa fragilità la esprime in maniera eclatante nella propria malattia fisica e psichica. C’è spesso una ispirazione cristiana che rimanda all’assunzione di un impegno vincolante alla testimonianza. C’è ancora un congenito impulso psichico a far prevalere il Noi di Buber all’Io, pericoloso e ingannevole protagonista di un solipsismo patologico.
Nasce dunque questo incredibile e meraviglioso incontro tra il volontario e il paziente. Anzi, no. Tra due persone. Perché chi giace a letto non è un paziente, non è un numero, non è uno sconosciuto e improvvido ospite della struttura, non è un povero disgraziato. E’ una persona. E soprattutto, come diceva Veronesi, “una persona da curare nell’anima prima che nel corpo”.
Non possiamo intendere questo incontro simile a quello del medico che fa diagnosi e terapia. Né possiamo concepirlo analogo a quello dell’infermiere o dell’ausiliario che fa il suo turno e rigorosamente rispetta il proprio mansionario. Non è un incontro di circostanza emerso da un generico senso del dovere. E’ un incontro radicalmente diverso, segnato da una insostituibile e rigida prerogativa: la generosità, e ancora dalla piena coscienza che si tratta di un incontro tra due fragilità. Mi piace a questo proposito citare sempre Andreoli quando scrive che in questo incontro c’è la suggestiva rappresentazione del limite, della precarietà, della debolezza, e perciò della necessaria comprensione che significa etimologicamente “andare verso”. “Il dolore compreso – scrive ancora Andreoli – diventa un’esperienza che non solo non è distruttiva, ma può essere persino umana e utile”.
Quando ci sono questi ingredienti l’incontro diventa un evento straordinario. Allora ha ragione Longhini quando dice che il paziente diventa improvvisamente il medico del volontario. Il Sé del volontario ed il Sé del paziente entrano nel gioco del dare e dell’avere, trasferendo la ricchezza dell’uno nell’altro in una corretta condizione di reciprocità. Non sono più due “Io” chiusi, ma due “Sé” comunicanti.
Questo scenario accattivante descrive dunque un incontro ideale dove la solidarietà si fa amore per l’alterità e dove il trionfo del “Noi” appare come l’ombrello protettivo contro le insidie di una diffusa psicopatologia. E’ il punto di arrivo di un autentico volontariato. Ma c’è un percorso lungo e complicato per arrivarci. Lungo questo percorso l’IO del volontario ha bisogno di essere esplorato profondamente. Qui è il cuore di questa riflessione. Lasciamo da parte la persona che soffre e concentriamo l’attenzione su questo IO che si propone come Sé comunicante.
E’ un IO che giunge da un suo individuale mondo di frustrazioni, di delusioni, di sofferenze, di lutti, di perdite importanti. E’ un IO che porta su di sé tante ferite. E’ un IO che ha bisogno di riconciliarsi con il mondo, di neutralizzare per quanto possibile i propri conflitti profondi, di costruire per sé una ricchezza interiore, una dote di umanità da poter poi trasfondere nell’altro. E’ un IO che deve sapersi sottoporre ad un giusto processo critico sui propri limiti e le proprie fragilità.
Non è un compito agevole. La tentazione di considerare, magari inconsciamente, chi giace a letto una persona subordinata, è fortissima, in misura che cresce dentro un proprio senso di onnipotenza. L’arroganza di sanare il suo male con un comportamento solidale, richiamandolo ad una reazione di semplice rassegnazione, costituisce una modalità sbagliata di approccio. Spesso l’offerta del conforto tramite il racconto delle proprie disgrazie diventa motivo di stravolgimento delle emozioni che scadono nel compassionevole.
In questo senso l’IO del volontario sofferente va aiutato a sciogliere preliminarmente i nodi dei suoi vissuti. Le sue personali frustrazioni vanno fatte sedimentare. La rabbia va sopita.
Oserei dire che sarebbe necessario un trattamento di analisi se non fosse che lo statuto AVO provvidamente assegna il compito di fare ascolto “in punta di piedi” senza eccessi di parole, né comportamenti baldanzosi di marca narcisistica. Nessuno può vantarsi di possedere le soluzioni in tasca. Oggi c’è il rischio grave di far emergere dal proprio inconscio un senso di onnipotenza. A tal proposito un eventuale rifiuto del malato all’incontro può concretamente divenire causa di burn-out per il volontario..
Giustamente Callieri richiama a “non arroccarsi in un delirio, a non cadere nell’autismo, a non affondare nel narcisismo.” Sono esattamente i pericoli in cui incorre il volontario.
Attorno al malato gravitano tante manifestazioni di disinteresse, di prestazioni lacunose, di gravi inadempienze strutturali, spesso di colpevoli distrazioni. Tutto questo rende l’umanizzazione un problema sempre attuale. Tocca al volontario fare semplice testimonianza sopperendo al difetto della comunicazione, della comprensione, dell’empatia.
Nell’era degli emoticon vale molto un sorriso, uno sguardo comprensivo, un silenzio rispettoso, lasciandosi alle spalle critiche, lamentele, conflitti, rivendicazioni. Perfino l’aspetto esteriore, l’abbigliamento, il portamento sono ingredienti di un incontro benefico. Il volontario è chiamato a questa mission per la quale, come appare evidente, si richiede necessariamente tanta formazione.
Ma forse il punto di partenza è la coscienza del Sé, dei propri limiti, e soprattutto dei profondi bisogni della persona che sta dall’altra parte a vivere una emergente, spesso grave condizione di sofferenza.
DOMENICO BARBARO- Vice Presidente AVO Isernia
